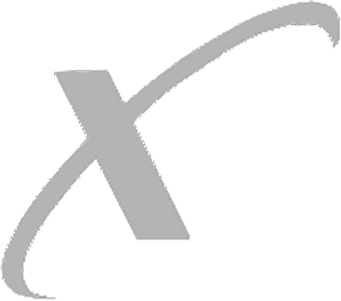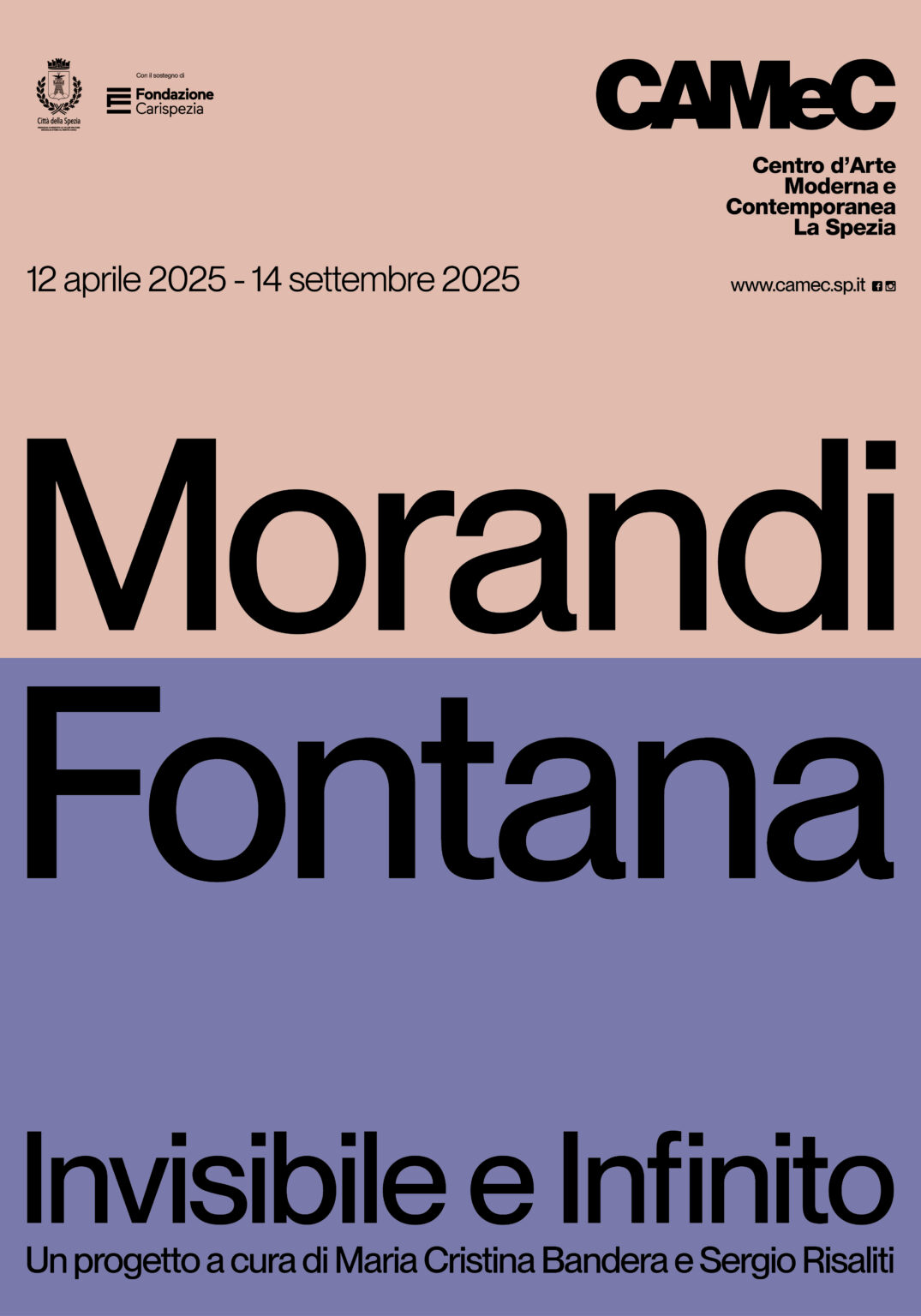Mostre
Beato Angelico, “evangelista pittore”. Firenze rimette insieme i pezzi (e la storia)
Beato Angelico, “evangelista pittore”. Firenze rimette insieme i pezzi (e la storia)
C’è un modo molto fiorentino di raccontare il Rinascimento: non comincia con una data, ma con una bottega che apre la mattina presto, l’odore della colla da doratore, un committente che passa, guarda, discute. In mezzo a queste cose concrete, un frate domenicano – Fra Giovanni da Fiesole, che tutti chiameranno Beato Angelico – costruisce immagini che parlano come Vangeli. Non è una metafora: nel 1955 Pio XII disse che l’Angelico “racconta le storie come se a narrarle fossero gli evangelisti stessi”. È una definizione felice, perché tiene insieme il pittore “moderno” del Quattrocento e il narratore capace di farci sentire umani i personaggi sacri. La ritroviamo oggi come chiave di lettura della grande mostra fiorentina, divisa tra Palazzo Strozzi e Museo di San Marco.
La rassegna (26 settembre 2025 – 25 gennaio 2026) è di quelle che non si montano tutti gli anni: circa 150 opere da oltre 60 musei e collezioni e, soprattutto, ricomposizioni che hanno il sapore dell’impresa. Le pale “esplose” tra Sette e Ottocento – smembrate, vendute a pezzi, disperse – vengono rimesse insieme per qualche mese, con prestiti che musei solitamente “severi” non concedono alla leggera. Capite bene che riportare a dialogare tavole partite per Berlino, Parigi, Londra, Dublino, Washington non è un dettaglio logistico: è un’operazione storica.
Gli artefici sono tre studiosi che i frequentatori di archivi riconoscono subito: Carl Brandon Strehlke (curatore emerito del Philadelphia Museum of Art), con Angelo Tartuferi e Stefano Casciu per San Marco. La cornice istituzionale è quella giusta – Fondazione Palazzo Strozzi con la Direzione regionale Musei nazionali Toscana – e il partner principale è Intesa Sanpaolo. Sono dati curatoriali, ma qui contano perché spiegano la forza del progetto: non un’antologia, bensì una ricostruzione (per quanto provvisoria) di contesti originali.
Prendiamo la Pala di San Marco (1438–1442 circa), commissionata da Cosimo il Vecchio: un insieme disseminato nel mondo, con predelle e scomparti che viaggiano da decenni. A Firenze la si evoca in una sala che, oltre al rimontaggio degli elementi, ne fa leggere il linguaggio: la prospettiva del trono mariano, la teatralità misurata dei santi Cosma e Damiano (che ai Medici, com’è noto, stavano a cuore), e quell’attenzione al realismo fiammingo che passa – anche – dai rapporti con Niccolò Albergati, committente di Jan van Eyck, richiamato in mostra da un piccolo San Girolamo (Detroit). È un Rinascimento che guarda al Nord con curiosità, e lo incorpora senza perdere l’accento fiorentino.

La mostra fa un’altra cosa utile: riordina il dialogo fra Angelico e i suoi vicini di banco. Masaccio – più anziano, morto presto – resta la scossa iniziale (il Trittico di San Giovenale da Reggello è un promemoria potente). Accanto, la filiera domenicana verso Filippo Lippi; e, prima ancora, la spinta gotica di Lorenzo Monaco. Non a caso si rimettono in campo l’Annunciazione della Cappella Bartolini Salimbeni, la Pala Strozzi con la Deposizione, e la predella dell’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano: una linea continua che va dall’oro del fondo al nuovo modo di organizzare lo spazio e i corpi. È il punto in cui il museo temporaneo diventa lezione di storia.
Qui l’Angelico “evangelista” torna utile. La sua capacità narrativa non è un’astrazione estetica: significa, molto concretamente, saper scegliere quando fermare l’azione e come far parlare i volti. Chi ha visto certe sue Madonne dell’Umiltà – sedute a terra, col Bambino che non fa il manichino ma il bambino – capisce. E capisce anche chi si ferma davanti al Cristo come Re dei Re (Livorno): lo sguardo ravvicinato, quasi “da toccare”, non è un effetto speciale; è un invito a misurarsi con il dolore e la maestà nello stesso istante. Non stupisce allora che, come ricorda Strehlke, Elsa Morante avesse visto nell’Angelico un “propagandista del Paradiso”: una formula brillante che dice la verità profonda di un artista capace di rendere visibile l’invisibile – qualità che, da Rothko a Hockney, i moderni non hanno smesso di stimare.
C’è anche un capitolo romano, e merita: gli anni di Eugenio IV e Niccolò V, la cappella vaticana del 1455, il cardinale Juan de Torquemada (il “buono”, come dicono gli storici per distinguerlo dall’inquisitore cinquecentesco). Qui l’Angelico affina quel tono liturgico-umano che lo rende inconfondibile. E la mostra aggiunge perfino una scoperta: una Crocifissione (1453–55) riemersa da una collezione privata, con santa Brigida di Svezia colta nell’istante in cui la cera di una candela le cade sulla spalla, a memoria del sangue caldo di Cristo. Un’immagine “estrema”, ma limpida come un appunto di cronaca.
Ora, non è che a Firenze non si sia più parlato di Angelico; ma che questa sia la prima grande retrospettiva cittadina dopo settant’anni dà la misura dell’occasione. E spiega la scelta del doppio luogo: Palazzo Strozzi per l’itinerario comparativo e i grandi prestiti; San Marco per il corpo a casa, dove l’Angelico affrescò le celle dei frati. Per chi insegna (o impara) storia dell’arte, vuol dire poter vedere la “vita prima e seconda” delle opere: la funzione originaria e l’esistenza museale.

ANGELICO_Virgen de la Humildad_7 (1986.10)
Qualcuno chiederà: e la teoria? C’è anche quella, ma al punto giusto. Georges Didi-Huberman – che nel 1991 ragionò sulle specchiature marmoree dell’Angelico – è richiamato per differenza: oggi, come osserva Stefano Casciu, preferiamo ancorare quei marmi finti ai rimandi scritturistici alle pietre dure (e, direi, a come l’Angelico usa il décor per parlare di teologia, non per imbrogliare l’occhio). È un sano rimettere i piedi a terra: prima che un problema di stile, qui c’è catechesi visiva. www.ilgiornaledellarte.com
Infine, una nota di metodo che piacerà a chi ama i fatti: l’intervista che accompagna il progetto – con Strehlke e Casciu, firmata da Laura Lombardi – è un piccolo manuale di lettura della mostra. Dentro ci trovate le ragioni dei prestiti, i criteri degli accostamenti, il perché di certe sale tematiche: croci sagomate (con un restauro ad hoc della Testa di san Francesco), volti di Madonne e volti di Cristo, fino agli incastri delle predelle. È la voce dei curatori che spiega il loro lavoro, senza patine retoriche. E, se mi permettete un giudizio “alla Barbero”, è così che si fa: si racconta come si è fatta la storia, non solo che cosa se ne pensa.
In sintesi: questa non è soltanto una mostra “bella” – lo sarà, inutile fingere blasé –; è una mostra istruttiva. Rimette in circolo opere lontane, fa vedere come si costruisce un altare e come si smonta, mostra la rete europea che già nel Quattrocento portava un frate fiorentino a guardare al Nord. E soprattutto conferma che l’Angelico è un grande narratore: uno che non ti schiaccia con la retorica del sacro, ma ti porta dentro la scena con la semplicità severa di chi ha qualcosa da dire e lo dice chiaro.
Riferimenti e crediti
-
Mostra “Beato Angelico”, Firenze, Palazzo Strozzi e Museo di San Marco, 26 settembre 2025 – 25 gennaio 2026 (info e orari ufficiali). Fondazione Palazzo Strozzi
-
Intervista a Carl Brandon Strehlke e Stefano Casciu, a cura di Laura Lombardi, Il Giornale dell’Arte, 3 settembre 2025 (“Beato Angelico, l’evangelista pittore”). Molte delle citazioni e dei dettagli provengono da qui. www.ilgiornaledellarte.com
-
Sulla portata storica dell’evento (“prima grande retrospettiva a Firenze dopo 70 anni”). exibart.com
Fonte: Canale Cultura -www.canalecultura.it